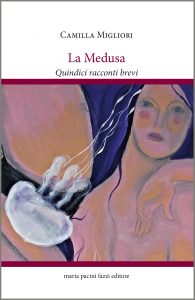Slittamenti progressivi dell’inquietudine. ‘La Medusa. Quindici racconti brevi’ di Camilla Migliori, maria pacini fazzi editore
In quasi tutti i racconti de La Medusa è una natura animata di derivazione romantica e trascendentalista a condurre il protagonista in uno spazio simbolico, isolandolo progressivamente da inganni e autoinganni quotidiani, per costringerlo a decifrare disagi, incubi e inquietudini.
Nella vicenda che dà il titolo alla raccolta, la giornata in spiaggia di una coppia, fra dune e ombrelloni a strisce gialle e verdi, si trasforma per Walter, perseguitato da un’indistinta apprensione, nell’indagine onirica che lo porterà di fronte a una recente colpa rimossa. Allontanatosi dalla moglie intenta a sfogliare giornali e stendere lo smalto sulle unghie dei piedi, camminando sotto un sole opprimente, si avvede della gelatinosa e pulsante presenza di una medusa. Un corpicino rosa, lucido e molliccio che allunga verso di lui le flaccide braccine emettendo piccole grida strozzate. Questa forma creaturale, da un lato assimilabile alle blatte vendicatrici di Landolfi e dall’altro all’innocente tartarughina del Levante dell’immensa Ortese (per tacere del puma Alonso dagli occhi paterni, del gatto Lucino, dell’Iguana e della farfalla addormita su una foglia), diventa l’Ombra di Walter. Nonostante i tentativi di eliminazione messi in atto dall’uomo, interramento compreso, i singhiozzi e i lamenti del piccolo essere continueranno a inseguirlo fino a riportare alla luce della coscienza un fatale incidente d’auto.
Le storie di Camilla Migliori sono abitate spesso da uomini che in un passato remoto o prossimo si sono macchiati di colpe inemendabili, e a giustiziarli arrivano, nel racconto Lo chiamavano Santo, morbi ripugnanti e letali. L’anziano maestro pedofilo Santo viene divorato da una diarrea allegorica che l’autrice descrive con una compostezza stilistica in grado di mutare in nitore di linee i particolari della devastazione organica. Non c’è alcuno sconfinamento nella gratuità orrorifica, bensì un finale impennarsi della febbre emotiva attraverso il personaggio di Nunzia, piccola e magra, e dell’indignazione che la induce a terminare l’opera iniziata dalla malattia. Alla resa dei conti con se stessi si arriva sempre attraverso complesse traiettorie interiori, seguendo le tracce de Il velo nero del pastore di Hawthorne, e il grumo che preme dolorosamente da qualche parte (dentro, direbbe Landolfi), delitto o trauma, assume la forma esterna di un segno distintivo enigmatico. Come accade ne La maschera di Giulia, racconto psicanalitico alla Schnitzler in cui le figure-specchio osservate dalla donna, fra cespugli di oleandri e paesaggi marini affocati, rivelano il groviglio di tagli e spaccature da lasciarsi alle spalle.
Qua e là le vicende s’increspano di contenuto sarcasmo, per esempio nel crudele Agib, parabola amarissima sull’egotismo rivestito di correttezza ipocrica in cui un immigrato dai capelli ingrigiti sotto uno strato di polvere viene ‘accolto’ da un benefattore in cerca di plauso che, con vaporosa ottusità, lo affama fino a provocarne la morte.
Struggente racconto sullo smarrimento e la nostalgia, Otto candeline lascia di nuovo il palcoscenico all’essenza perturbante della Natura in uno straordinario ‘notturno’ attraversato con sgomento dall’anziano Antonio. Mentre ricorda la mamma addormentata al sole, viene avvolto dal buio che, addensandosi, prende spazio e consistenza: gli occhi di Antonio cercavano invano una fessura che traforasse quel nero mantello cupo, cercava un varco illuminato, ma più niente ormai poteva essere bagnato dalla più piccola goccia di luce.