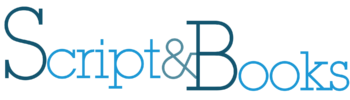Fedra di Racine al Piccolo: furore/orrore in una lucida dimensione di sogno
@Rinaldo Caddeo, 13 aprile 2025
 La regia di Federico Tiezzi accudisce la svolta Sturm und Drang, post-barocca e pre-romantica, travestita da classicismo, del linguaggio, a partire dal dispositivo desiderante apparecchiato per Fedra.
La regia di Federico Tiezzi accudisce la svolta Sturm und Drang, post-barocca e pre-romantica, travestita da classicismo, del linguaggio, a partire dal dispositivo desiderante apparecchiato per Fedra.
Due lemmi scandiscono la Fedra di Racine: furore e orrore.
Furore è la linea dominante dell’amore di Fedra per il figliastro Ippolito. Furore vuol dire desiderio, tortura, collera, colpa, gelosia, follia. Questi significati si radunano in una matassa rotante che genera e sospinge l’azione e le reazioni. A corte viene considerata il nemico numero uno di Ippolito dato che lo respinge mentre segretamente lo adora. È una tattica di depistaggio per allontanare ogni sospetto? C’è dell’altro. In fondo all’anima di Fedra scorre un torrente buio.
Racine vuole censurare o coprirlo con un velo? Il fitto, elegante ricamo degli alessandrini, tradotto da Giovanni Raboni, occulta ma sottintende e profila il mostro. Racine è un maestro di questo ordito mimetico: alla fine di ogni cesura, alla fine di ogni verso, dentro le rime, s’insinua, invisibile flusso, l’incognito dissimulato.
L’amore è fonte di aberrazioni. La madre Pasifae, per una vendetta di Venere, s’innamora e si accoppia con un toro, generando il Minotauro, rinchiuso al centro del Labirinto.
 Il Labirinto, con i suoi mostri e misfatti, è il sottofondo latente di amore/morte.
Il Labirinto, con i suoi mostri e misfatti, è il sottofondo latente di amore/morte.
Fedra definisce un mostro orribile, associandola implicitamente con il Minotauro, la passione che la divora. Incita Ippolito a liberare il mondo dal mostro, trafiggendo il suo cuore. E a Ippolito riluttante, sottrae la spada per essere lei stessa a penetrarsi.
Quando Teseo, dato per morto, ritorna sano e salvo da un’ennesima impresa, Fedra pensa di suicidarsi con quella spada ma Enone, nutrice e consigliera, la convince a rovesciare ogni responsabilità su Ippolito, accusandolo di aver tentato di oltraggiarla e la spada è prova regina.
Teseo è furibondo. Accusa Ippolito di essere un infame, un mostro. Lo scaccia. Nelle sue parole ritorna horreur in rima con fureur. Non servono le frasi reticenti di Ippolito, la confessione del suo amore per Aricia. Teseo lo accusa di essere un ipocrita e invoca la vendetta di Nettuno.
Ippolito si rifugia nell’amore, integro e ricambiato, per Aricia. Ma non c’è salvezza. I mostri sono stati provocati. A loro non si può sfuggire. Gli dei non dimenticano, non perdonano.
Dalla schiuma del mare si solleva un mostro furioso. È una macchina multipla di morte: la fronte armata di corna minacciose, il corpo coperto di squame giallastre, toro e dragone, si rattrappisce e si scaraventa sull’eroe solitario. Ippolito lo ferisce ma non basta.
La forza molteplice del mostro pagano non può essere fermata. Il carro da guerra su cui Ippolito intraprende la lotta va in pezzi. Ippolito è impigliato nelle redini. I suoi cavalli lo trascinano terrorizzati e lo maciullano. Questo finale vorticoso e insanguinato vive nella narrazione raccapricciata di Teramene.
Fedra, confessata a Teseo la sua colpa, si suicida con un veleno ereditato da Medea. A Teseo non resta che piangere la morte del figlio e restituirgli l’onore.
 Tiezzi fornisce un palcoscenico che scava l’occulto.
Tiezzi fornisce un palcoscenico che scava l’occulto.
Una tela dietro, Atalanta e Ippomene di Guido Reni (poi una lupa ritorta, poi un bonsai). Due lampadari identici, in alto, non illuminano. In basso due mezzi busti efebici spiccano dal buio con il loro biancore, di profilo, due a sinistra, due a destra. Questi elementi scenici costruiscono la prospettiva e incorniciano la geometria binaria del furore/orrore ma anche dei personaggi doppi, l’uno la prosecuzione e la persecuzione dell’altro (Ippolito/Teramene, Fedra/Enone, Fedra/Ippolito, Aricia/Ismene, Fedra/Teseo ecc.), che si ripropone nel bianco e nero dei vestiti, con abiti onirici, tra il ‘600 e Alice in Wonderland, forme arrotondate, superfici speculari, sbarluccicanti, bianchi ventagli, candide gorgiere che mettono in risalto il volto. Teseo con strane lenti multiple a cannocchiale che impediscono più che aiutare la vista, Fedra, in nero e in bianco, al centro di questo campo di forze.
La recitazione: l’ansito affannoso, la pronuncia veemente, la gestualità smaniosa, alla Sarah Bernhardt, talvolta razionale, spesso delirante, di Fedra (Elena Ghiaurov), non cancella la musica delle rime, levigata e sensuale, dei versi di Racine ma conferisce loro una stranita/straniante lucentezza che le solleva in un altrove di chiarezza e stupore. Così gli altri attori, ciascuno a suo modo, non sono meno incisivi, meno straniati: Ippolito (Riccardo Livermore) con leale, melancolico cruccio, Aricia (Catherine Bertoni de Laet) con arcana voluttà, Teseo (Martino D’Amico) con inclemente, fulgida e gelida determinazione, Bruna Rossi (Enone) con valetudinaria chiaroveggente sprezzatura, Massimo Verdastro (Teramene) con la pietas di un consigliere e l’angoscia di un padre-fratello, Valentina Elia (Ismene) con levità.
Pubblico silenzioso, attento. Prolungato, meritato scroscio di applausi.
Fedra
di Jean Racine
traduzione Giovanni Raboni
regia Federico Tiezzi
con Catherine Bertoni de Laet, Martino D’Amico, Valentina Elia, Elena Ghiaurov, Riccardo Livermore, Bruna Rossi, Massimo Verdastro
scena Franco Raggi, Gregorio Zurla e Federico Tiezzi
costumi Giovanna Buzzi
luci Gianni Pollini
canto Francesca Della Monica
movimenti coreografici Cristiana Morganti
regista assistente Giovanni Scandella
costumista assistente Lisa Rufini
scenografa assistente Erika Baffico
produzione Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale, Teatri di Pistoia Centro di Produzione Teatrale, Compagnia Lombardi-Tiezzi
Al Teatro Strehler dal 9 al 17 aprile